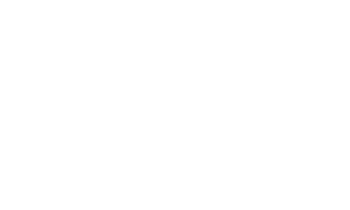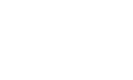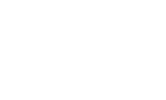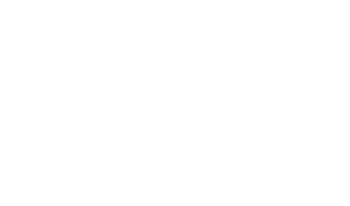Storia
del tartufo
Raccontiamo il tartufo
4000 anni insieme
Il tartufo ha origini antichissime.
Basti pensare che alcuni studiosi ritengono che questo raro prodotto della terra era già conosciuto, e consumato, al tempo dei Sumeri (mischiato a vegetali e legumi) e dei Babilonesi (IV-II millennio a.C.).

IL TARTUFO NEL MONDO ANTICO
La prima vera testimonianza diffusa in Europa, la si può trovare nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (23-79 d.C.).
Gli aneddoti riportati hanno rivelato che il tartufo, in latino denominato terrae tuber (escrescenza della terra) o semplicemente tuber, era molto apprezzato a tavola dagli antichi Romani che avevano copiato l’uso culinario dagli antichi Etruschi.
Anche i greci usavano il tartufo nella loro cucina, come dimostrato dal filosofo Plutarco di Cheronea che tramandò, a quei tempi (I secolo d.C.), l’idea che il raro e pregiato fungo nascesse dalla combinazione di alcuni elementi naturali come acqua, calore e fulmini.
Da questa teoria prese spunto il poeta Giovenale secondo il quale l’origine del tartufo si deve ad un fulmine scagliato dal padre degli dei, Giove, in prossimità di una quercia.
Oltre a ciò, dato che Giove era famoso per la sua prodigiosa attività sessuale, il tartufo veniva considerato altamente afrodisiaco. In base a questo suo potere un’altra leggenda narra che il tartufo fu dedicato dai pagani alla dea Venere.
Nonostante il prezioso fungo fu trattato da studiosi, filosofi e poeti, l’origine del tartufo non fu mai stabilita.
Ecco perché la scarsissima conoscenza unita alle credenze popolari, fece pensare del tartufo come un’escrescenza degenerativa del terreno e nel corso degli anni come cibo del diavolo o delle streghe.
Il rinascimento
Nel medioevo del tartufo se ne perde traccia fino a quando non ricompare nell’età rinascimentale tra le tavole delle nobili Caterina de’ Medici e Lucrezia Bolgia, oltre che nei banchetti più prestigiosi d’Europa.
Il primo vero trattato, riguardante interamente il tartufo, lo si deve al medico umbro Alfonso Ciccarelli scritto nel 1564 dal titolo “Opusculus de tuberis”.
Nello stesso secolo, inoltre, Andrea Cesalpino nomina per la prima volta i tartufi tra i funghi. Nell’Europa di questo periodo il tartufo veniva anche denominato “aglio del ricco”, a causa del suo leggero odore riconducibile alla pianta oltre a trovarne in quantità notevoli. In Piemonte, nel 1600, se ne faceva un consumo rilevante per imitare quelli della Francia.
A differenza dello stato transalpino, dove si trovavano quelli neri, nella regione piemontese si consumavano quelli bianchi.
Un secolo più tardi, il tartufo bianco piemontese era considerato da tutte le corti europee come una delle cose più pregiate.
Infatti, la ricerca del tartufo era considerata come un divertimento di palazzo per cui gli ospiti e gli ambasciatori stranieri venivano invitati a parteciparvi.

FINO AGLI INIZI DEL ‘900
Nel ‘700, il Conte de Borch pubblica una monografia sul tartufo denominata “Lettres surles truffes du Piemont”, mentre Vittorio Pico nel 1788 descrive il tartufo bianco chiamandolo con il nome di Tuber Magnatum.
Però, solo nel 1831 si ottiene la prima descrizione scientifica del prezioso fungo ipogeo, grazie alla “Monographia Tuberacearum” scritta da Carlo Vittadini.
In questo libro il botanico e micologo italiano descrive molte specie di tartufo, ecco il motivo per cui come molte di queste portano ancora il suo nome (Tuber Melanosporum Vittad, Tuber Aestivum Vittad, Tuber Brumale Vittad ecc..).
Con la pubblicazione di questo libro nasce l’idnologia (dal greco Hydnon), la scienza che ancora oggi studia i tartufi.
Dopo di ciò si arriva fino al 1929 per parlare del personaggio principale per il mondo dei tartufi: Giacomo Morra.
Il noto ristoratore e albergatore di Alba ebbe la brillante idea di rendere il tartufo bianco (denominato da lui stesso “Tartufo d’Alba) un oggetto di culto internazionale, creando attorno al prezioso fungo un evento di richiamo sia turistico che gastronomico.
Oltre a ciò, ebbe anche l’idea di inviare ogni anno un prezioso tartufo ad un personaggio famoso come: il presidente degli Stati Uniti Harry Truman nel 1951, il primo ministro inglese Winston Churchill nel 1953, lo sportivo Joe Di Maggio e l’attrice americana Marylin Monroe nel 1954.